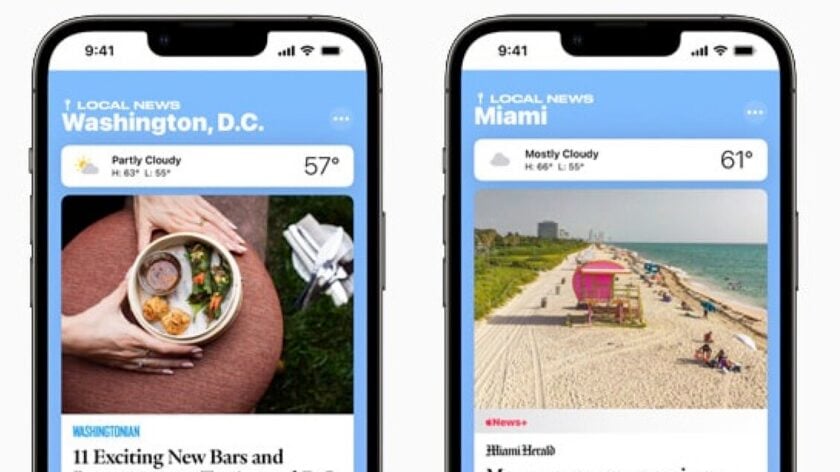Consumiamo le energie migliori prima dei sessant’anni e poi lasciamo inutilizzata l’esperienza. Il problema non è la pensione: è il modello di vita.
Viviamo più a lungo. Molto più a lungo di quanto vivessero i nostri nonni. In Italia l’aspettativa di vita ha superato gli 83 anni di media (dati ISTAT 2024), con donne oltre gli 85 e uomini sopra gli 81. Significa che una parte consistente della popolazione vivrà circa vent’anni – e spesso di più – dopo l’uscita dal lavoro.
Eppure continuiamo a organizzare la vita come se quei vent’anni fossero una parentesi marginale.
Si studia fino ai venticinque anni, si lavora quaranta ore settimanali – nella teoria – per oltre quattro decenni, si arriva a 60–67 anni con energie consumate, e solo allora si concede spazio alla libertà. Ma quando quel momento arriva, spesso non si ha più la stessa forza fisica o mentale per costruire, incidere, trasmettere.
Il problema non è la pensione. È il modello.
Oggi un lavoratore italiano resta formalmente in azienda 40 ore a settimana. Ma le ore effettive di vita dedicate al lavoro sono molte di più: tempo di spostamento, pausa obbligata che diventa tempo morto ma “vincolato”, riunioni, straordinari impliciti, reperibilità digitale. L’OCSE indica per l’Italia circa 1.694 ore lavorate all’anno in media (OECD Economic Survey 2024). L’Eurostat stima una settimana effettiva media in Europa di 36 ore, ma questo dato non racconta la dimensione psicologica e logistica del tempo sottratto alla vita.
Se una persona si sveglia alle 7 e rientra alle 19, la sua giornata è già stata assorbita. E lo sarà per quarant’anni.
E proprio quando l’esperienza accumulata potrebbe diventare guida per le generazioni successive, il modello attuale la spinge ai margini.
Qui nasce la contraddizione.
Formiamo una persona per decenni. La rendiamo competente, esperta, capace di visione. Le facciamo attraversare cambiamenti politici, tecnologici, sociali. E proprio quando raggiunge la piena maturità umana e professionale, la accompagniamo lentamente ai margini. Come se fosse diventata superflua.
È un paradosso organizzativo prima ancora che etico.
La vera domanda non è se si debba lavorare fino a 67 anni o se si debba anticipare di qualche quota. La domanda è: perché concentrare quasi tutto il lavoro nella fase centrale della vita, lasciando alla maturità il ruolo di parcheggio?
Esistono alternative. Non utopie, ma sperimentazioni reali.
In Islanda, tra il 2015 e il 2019, la riduzione della settimana lavorativa a 35–36 ore ha mostrato che la produttività può restare stabile o migliorare, mentre il benessere aumenta sensibilmente. In diversi Paesi nordici il dibattito non è più “se” ridurre l’orario, ma “come” ridistribuire il tempo in modo più sostenibile.
La proposta può sembrare radicale, ma è coerente con l’evoluzione demografica: lavorare sei ore al giorno e non oltre i sessant’anni. Non significa lavorare meno in senso improduttivo. Significa lavorare meglio e più intensamente nella fase centrale, lasciando spazio continuo a cultura, formazione personale, partecipazione sociale.
Una persona che lavora sei ore al giorno può coltivare competenze culturali, relazioni, hobby, attività civiche. Arriva a sessant’anni con un bagaglio qualitativamente più ricco e con energie ancora spendibili. Da quel momento in poi può dedicarsi alla trasmissione di esperienza, al mentoring, alla comunità, al volontariato qualificato, alla formazione delle nuove generazioni.
Oggi facciamo l’opposto: si brucia l’energia migliore nella fase produttiva e poi si lascia l’esperienza inutilizzata.
In Giappone, una delle società più longeve al mondo, esistono programmi di reinserimento attivo dei senior in ruoli leggeri e di mentoring. Nei Paesi scandinavi si investe sull’invecchiamento attivo come risorsa e non come costo. Non sono modelli perfetti, ma dimostrano che la questione non è anagrafica: è culturale.
Aristotele parlava di “vita buona” come equilibrio tra attività produttiva e contemplativa. Hannah Arendt distingueva il lavoro – necessario alla sopravvivenza – dall’azione, che costruisce senso collettivo. Seneca ricordava che non è breve la vita, ma il tempo che sprechiamo.
Oggi abbiamo allungato la vita biologica, ma non abbiamo ripensato l’architettura del tempo sociale.
Se l’aspettativa di vita cresce, se la popolazione invecchia, se il sistema sanitario è sotto pressione, la soluzione non può essere semplicemente lavorare più a lungo. Una persona meno stressata, meno logorata da quaranta anni di carichi eccessivi, ha meno probabilità di sviluppare patologie croniche legate allo stress. Il benessere non è un lusso: è sostenibilità economica.
Il vero radicalismo non è proporre un modello diverso.
Il vero radicalismo è continuare a fingere che quello attuale funzioni.
Una società matura non rottama le sue stagioni più ricche.
Le integra.
Non si tratta di lavorare meno.
Si tratta di vivere meglio per essere più utili, più a lungo.
E forse il futuro non è prolungare la fatica.
È redistribuire il tempo della vita con intelligenza.
The Integrity Times
Independent Journalism. Unbiased. Uncompromised.
Riproduzione riservata © Copyright “The Integrity Times“