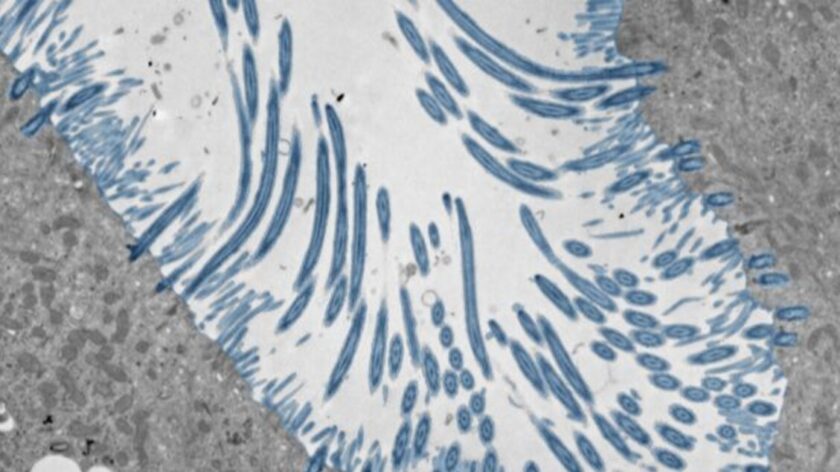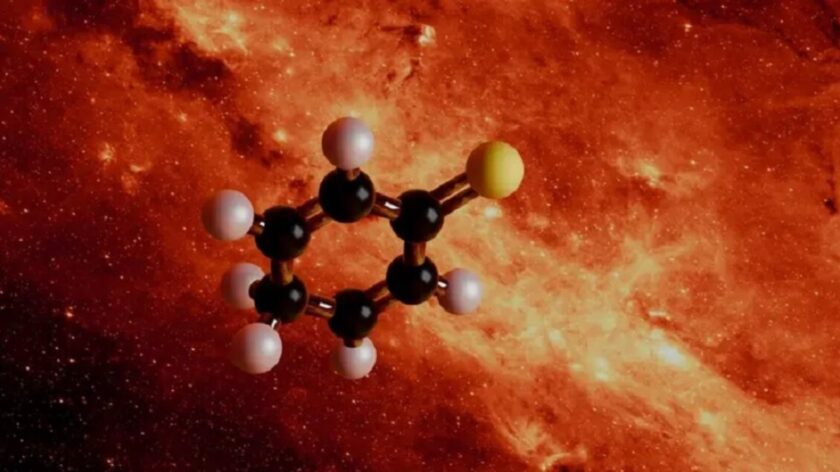PNRR, fondi europei e il costo nascosto del precariato accademico
In Italia, da anni, sentiamo ripetere lo stesso mantra:
“Bisogna puntare sui giovani, sulla ricerca, sull’innovazione.”
Nel frattempo, dentro le università succede altro: ondate di ricercatori precari che entrano con bandi a tempo e vengono espulsi quando i fondi finiscono, come se fossero una variabile sacrificabile del sistema.
Negli ultimi mesi la frattura è esplosa in piena luce. Secondo i dati della FLC CGIL, l’università italiana è sottofinanziata di circa 1 miliardo di euro, e solo nel 2024 i tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario hanno raggiunto i 419 milioni.
Su questa base fragile si è innestato il PNRR: una pioggia di fondi straordinari che ha permesso di assumere migliaia di ricercatori a tempo determinato. Ora che quei soldi stanno finendo, il conto arriva puntuale: decine di migliaia di persone rischiano di essere semplicemente espulse dal sistema.
Mentre l’Europa annuncia 7,3 miliardi di euro per il solo Work Programme 2025 di Horizon Europe, con un forte focus su carriera e competitività della ricerca, l’Italia continua a comportarsi come un Paese che usa i ricercatori come manodopera temporanea, non come infrastruttura strategica.
Il paradosso italiano: più fondi, più precarietà
Negli ultimi anni, il PNRR e i programmi europei hanno portato nelle università italiane una quantità di risorse inedita. Horizon Europe – il più grande programma pubblico di ricerca e innovazione al mondo, con una dotazione complessiva di 95,5 miliardi di euro per il periodo 2021–2027 – ha messo a disposizione bandi, progetti, mobilità, nuove linee di ricerca.
Ma chi tiene in piedi, ogni giorno, questi progetti?
In larga parte ricercatrici e ricercatori precari: assegni di ricerca (fino a ieri), contratti a tempo determinato “tipo A”, borse su fondi esterni. Figure che:
- garantiscono didattica, laboratori, scrittura di progetti, rendicontazioni;
- sono spesso pagate meno di quanto costerebbe uno specialista in azienda con competenze analoghe;
- non hanno alcuna certezza di rimanere nel sistema oltre la durata del singolo finanziamento.
La XII indagine dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca) parla esplicitamente del precariato come condizione strutturale dell’università italiana, non più come fase transitoria: migliaia di post-doc che vivono di contratti brevi, con prospettive di stabilizzazione minime.
Per anni lo strumento principale per i giovani ricercatori è stato l’assegno di ricerca; nel 2025 è stato abolito in linea con una milestone del PNRR, proprio perché troppo precario. Ma la domanda è: cosa è arrivato davvero al suo posto?
Più contratti stabili o solo nuove etichette per la stessa insicurezza?
L’università “a tempo determinato”
I sindacati parlano di oltre 35.000 precari inseriti negli atenei negli ultimi anni.
Molti di loro vedranno scadere i contratti tra il 2025 e il 2027, in parallelo con l’esaurirsi dei fondi PNRR. Le stime delle sigle di categoria sono brutali: fino a due terzi di queste persone rischiano di restare semplicemente fuori dal sistema.
Non parliamo di “giovani che fanno un’esperienza”:
parliamo di ricercatori e ricercatrici con alle spalle:
- dottorato,
- anni di post-doc,
- pubblicazioni internazionali,
- responsabilità di laboratorio e di didattica.
Persone che, dopo dieci o più anni dentro l’università, si sentono dire che semplicemente non c’è più budget per loro.
Non è solo una questione individuale.
È un modello di università che funziona così:
- Usa fondi straordinari (PNRR, progetti europei) per “gonfiare” temporaneamente il personale.
- Non corregge il sottofinanziamento strutturale del sistema.
- Quando i fondi finiscono, scarica il costo sui corpi: espulsione di massa dei precari, nuovo giro tra i bandi, nuovo ciclo di precarietà.
È una sorta di “università usa e getta”, che non si può più chiamare fisiologica. È una scelta politica.
L’Europa investe nei ricercatori, l’Italia li perde
Mentre qui si discute di come “far quadrare i conti”, Bruxelles manda segnali chiari:
- il Work Programme 2025 di Horizon Europe destina 7,2–7,3 miliardi di euro a ricerca e innovazione, con una quota significativa dedicata a carriera scientifica, mobilità e rafforzamento delle competenze.
- la Commissione ha proposto di raddoppiare il budget complessivo per il dopo-2027, puntando a 175 miliardi per il futuro programma di ricerca 2028–2034.
In parallelo, le agenzie europee iniziano a chiedere con forza che chi lavora sui progetti sia assunto con contratti di lavoro veri, non borse o assegni mascherati, proprio per evitare abusi e precarietà croniche.
Il rischio concreto è paradossale:
l’Europa finanzia ricerca di qualità, chiede condizioni più stabili per chi lavora nei progetti… e l’Italia risponde non stabilizzando, ma perdendo i suoi ricercatori migliori, spinti all’estero o fuori dall’accademia.
Il “brain drain” non è più solo una vecchia espressione: è la conseguenza logica di un sistema che chiede a una generazione di vivere in sospeso fino a 40–45 anni e poi, spesso, di cambiare mestiere.
Cosa proporrebbe un Paese che prende sul serio ricerca e università
Con lo sguardo di The Integrity Times, la domanda non è “come trattenere qualche talento in più”, ma:
Che sistema universitario costruiremmo se mettessimo davvero al centro le persone che fanno ricerca, e non solo i progetti che li pagano?
Tre linee di azione, molto concrete.
1. Legare i fondi straordinari a posti stabili, non a contratti a scadenza
Ogni grande programma di finanziamento (PNRR, Horizon, bandi nazionali) dovrebbe:
- prevedere una quota obbligatoria di risorse destinata a posizioni strutturate (ricercatori tenure-track, RTD-B, profili di lungo periodo);
- limitare il numero di contratti ultra-precari attivabili con quel denaro.
In altre parole: se arrivano soldi eccezionali, devono lasciare strutture permanenti, non solo cicatrici personali.
2. Un’anagrafe pubblica del precariato accademico
Oggi i numeri circolano a pezzi: sindacati, associazioni, singoli atenei.
Un Paese che fa sul serio avrebbe:
- una banca dati nazionale aggiornata su tutti i contratti non strutturati nelle università (tipologia, durata, retribuzione, ente finanziatore);
- una pianificazione triennale su quante di queste posizioni possono, realisticamente, diventare stabili.
Senza trasparenza, il precariato resta un fenomeno “emotivo”, non un problema politico misurabile.
3. Valutare gli atenei anche per come trattano chi lavora
Oggi le università sono valutate principalmente per:
- numero di pubblicazioni,
- capacità di attrarre fondi,
- posizionamento internazionale.
Un indicatore mancante è la qualità delle condizioni di lavoro del personale precario:
- tasso di stabilizzazione entro un certo numero di anni,
- durata media dei contratti,
- rapporto tra docenti strutturati e personale non strutturato.
Inserire questi parametri nei sistemi di valutazione – e quindi nei meccanismi di finanziamento – significherebbe dire agli atenei:
“Non basta vincere bandi. Conta anche come tratti chi te li fa vincere.”
Perché questo non riguarda solo l’accademia
Potrebbe sembrare un tema da addetti ai lavori. Non lo è.
Ogni volta che:
- un ricercatore in biomedicina lascia l’università per un contratto a termine in azienda;
- una matematica che lavorava su algoritmi complessi cambia mestiere perché non regge più l’insicurezza;
- un umanista che tiene insieme tre contratti in tre città diverse decide di mollare,
non è solo una storia personale che si spegne.
È un pezzo di capacità collettiva di capire il mondo che si assottiglia.
Università e ricerca non sono un lusso per tempi buoni:
sono la condizione minima per non trovarci, domani, senza strumenti di fronte a crisi climatiche, guerre ibride, rivoluzioni tecnologiche.
Oggi l’Europa sta dicendo: “Investiamo di più, vogliamo un ecosistema forte, competitivo, giusto”.
L’Italia, se continua a bruciare i suoi ricercatori a ciclo continuo, rischia di fare la parte del Paese che usa i fondi europei per tappare i buchi e non per costruire il futuro.
La scelta, come sempre, non è neutra.
Possiamo restare un sistema che vive di bandi e di persone a tempo,
oppure cominciare a considerare ogni ricercatore non come una spesa eventuale, ma come un pezzo di infrastruttura essenziale, al pari di una strada o di un ospedale.
Perché, alla fine, la domanda vera è una sola:
Che idea di Paese c’è dietro il modo in cui trattiamo chi prova a pensare il nostro domani?
Riproduzione riservata © Copyright “The Integrity Times“